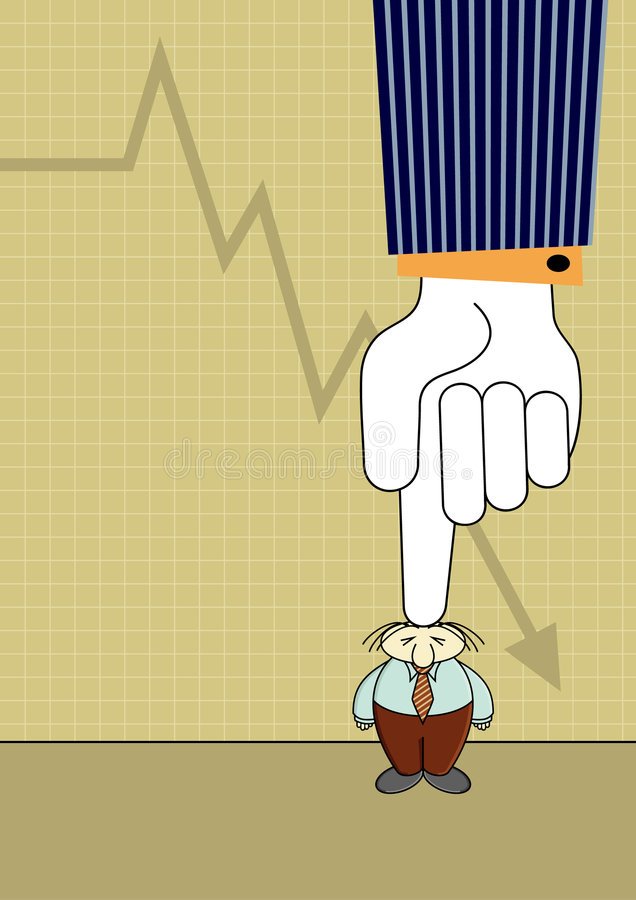Un tempo non ci ponevano tante domande in ufficio: se il capo era un farabutto c’erano modo e maniera per vendicarsi. Oppure per denunciarlo. Oggi la terminologia inglese ci pone davanti un altro ostacolo sul posto di lavoro: lo straining. Altro non è che l’enensima angheria sofferta dal lavoratore messo apposta sotto pressione.
Roma – Oggi sei più…straining del solito! Di primo acchito, quando si ha a che fare con questa locuzione, immediatamente si pensa che possa essere la traduzione dell’italico aggettivo strano in inglese. Si resta persuasi di ciò dal fatto che, ormai, gli inglesismi sono diventati pane quotidiano nella comunicazione interpersonale e non. Ed invece, altro che stranezze. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria patologia. ovverosia quando la pressione sul lavoro raggiunge livelli intollerabili per la persone che ne è vittima. La terminologia risale agli inizi del nuovo millennio nell’ambito della psicologia del lavoro.
Si tratta di un neologismo di origine anglosassone (dal verbo “to strain”, mettere sotto pressione) per definirà una costante condotta di persecuzione nell’ambiente lavorativo, per cui la vittima si trova in stato di continua inferiorità nei confronti di colui che, con intenzionalità, attua lo straining. Si è, quindi, prospettato, nel quadro più ampio delle prevaricazioni nel mondo del lavoro, questa nuova definizione. Non è che se ne sentisse la necessità, dopo che si era già al completo col “mobbing” e lo “stalking occupazionale“! La sua utilità pratica deriva dalla constatazione che quelle angherie che non rientravano nel modello studiato dalle scienze psicologiche non avevano collocazione.

Basti pensare alla molteplicità di azioni ripetute in un breve lasso di tempo, aspetti, questi, che rientrano sia nel mobbing che nello stalking. Si intende, ad esempio, il dimensionamento o l’inattività lavorativa per costrizione, che si concretizza in un atto vessatorio con effetti negativi permanenti. E’ un caso significativo che mostra le caratteristiche fondamentali dell’agire dello straining.
Il concetto emerso dalle scienze psicologiche, pur nel vuoto legislativo nazionale, è stato accolto, istantaneamente, dalla giurisprudenza italiana. La base giuridica da cui si è partiti è stato il codice civile riferito alla “Tutela delle condizioni di lavoro“. Fino al 2018 lo straining è stato definito come “mobbing attenuato” ed è rientrato nella categorie delle persecuzioni lavorative, evidenziando non tanto l’illegittimità del comportamento vessatorio, quanto la precisa volontà di perseguitare la vittima.

In seguito, una sentenza della Cassazione introdusse una variante al concetto di straining delineatosi fino ad allora, facendovi rientrare tutte la attività stressogene che avrebbero potuto intaccare il benessere del lavoratore, anche in caso di mancata prova dell’intento vessatorio. Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale definisce “straining” ogni “situazione lavorativa che provochi un danno all’integrità psico-fisica del dipendente, come, ad esempio, superlavoro, mancata fruizione di ferie e riposi, postazioni lavorative carenti delle misure minime di sicurezza“. Non rientrerebbero in questo paradigma le percezioni derivanti dalla considerazione usurante dell’ordinaria prestazione lavorativa.

Quindi, i cosiddetti “disagi soggettivi” non hanno diritto di cittadinanza perché rientrerebbero nell’ordinarietà. Infine, si resta delusi dalla constatazione che la categoria “Lavoro” di per sé sia prevaricante. Nel senso che è spietata, inesorabile e senza scampo. Se lo si ha, il lavoro, può provocare burnout, mobbing e in ultimo, straining. Se non lo si ha, ci si trova nell’incapacità di sopravvivere e si rischia di cadere in stadi depressivi, fino ad arrivare a gesti estremi come il suicidio. In entrambi i casi ci si ammala. Possibile che non ci siano rimedi per sfuggire ai suoi tentacoli? Meno male che siamo gli esseri più intelligenti del creato!