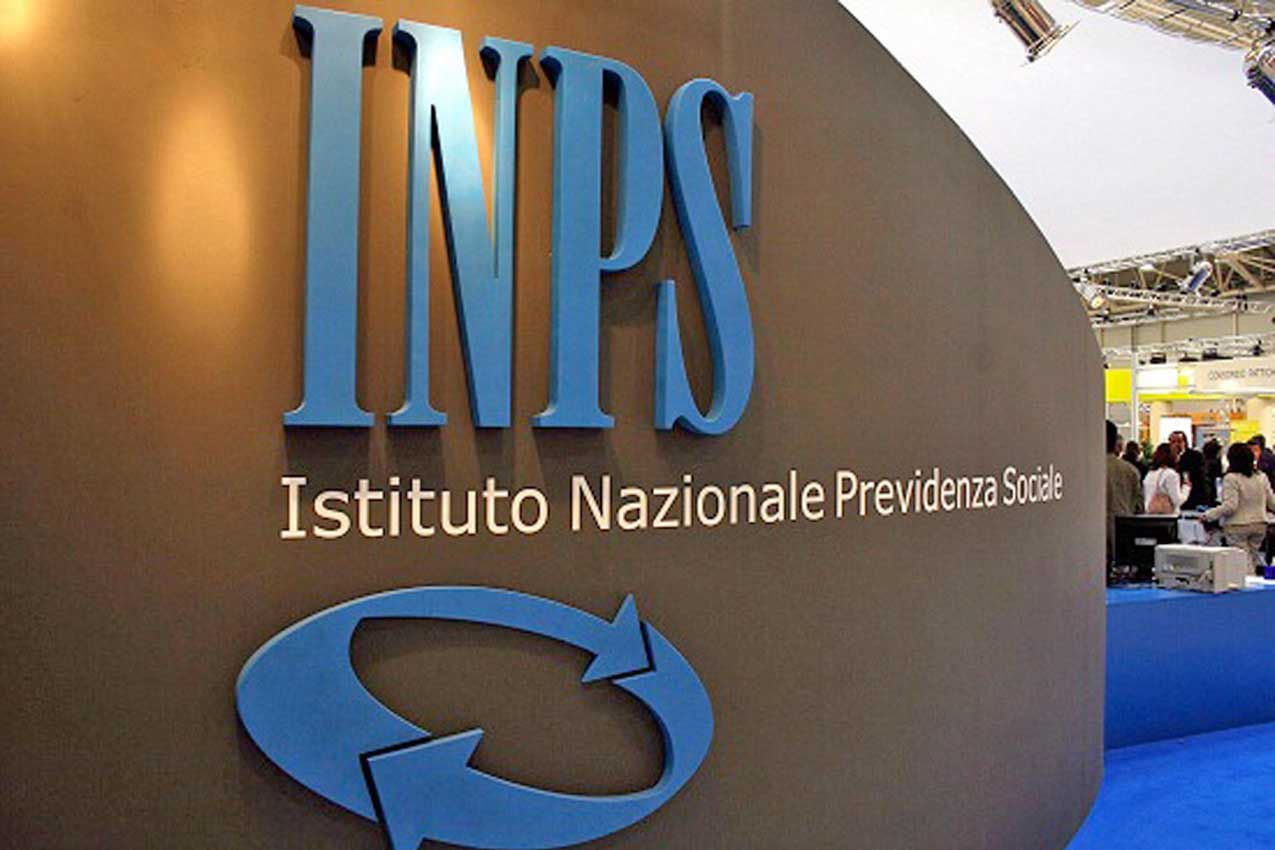Enti costretti a cedere 396 immobili a prezzi stracciati, poi inquilini della propria casa per 18 anni. Il conto finale: 8 miliardi bruciati per ricomprare quello che era già nostro.
Roma – Provate a immaginare di dover vendere la vostra abitazione perché avete bisogno urgente di liquidità. Incassate dalla vendita un milione di euro. Ma non potendo traslocare, siete obbligati a rimanere lì come affittuari, versando al nuovo padrone di casa un canone dell’8% annuo – il doppio del normale – più tutte le spese di ristrutturazione. Un contratto blindato per diciotto, lunghi anni. Al termine, se volete continuare a vivere nella vostra ex casa, dovete ricomprarla a prezzo maggiorato. Bilancio dell’operazione: un milione guadagnato, tre milioni persi.
Quello che per un privato sarebbe un suicidio finanziario, per lo Stato italiano è diventata realtà con una delle operazioni più scellerate della storia repubblicana. Una manovra che ha trasformato il patrimonio immobiliare pubblico in una macchina da soldi per speculatori e fondi privati, costando ai contribuenti oltre 8 miliardi di euro.
L’emblema del disastro: la sede Inps di Bari
La storia del palazzo dell’Inps di Bari racconta tutto il paradosso di questa vicenda. Lungomare Nazario Sauro 41, posizione da sogno sul mare pugliese. Nel 2004 l’edificio viene ceduto insieme ad altri 395 immobili statali al Fondo Immobili Pubblici (Fip), gestito dalla Sgr InvestiRe del banchiere milanese Giampietro Nattino, per circa dieci milioni di euro.

Il Fip lo rivende poi alla società Luigi Dimola & figli, che lo acquista con un mutuo di 9 milioni dal Monte dei Paschi di Siena. Per diciotto anni, lo Stato – che non può trasferire i propri uffici – paga un affitto lievitato progressivamente fino a sfiorare il milione di euro annui nel 2020: precisamente 951.253,27 euro. Non solo: come stabilito dal contratto capestro, lo Stato sostiene anche tutte le spese per le manutenzioni straordinarie, dagli infissi agli impianti di condizionamento.
Il 31 dicembre 2022 scadono i diciotto anni. Lo Stato non ha scelta: o ricompra l’immobile o perde definitivamente la sede. Il prezzo? Ben 12 milioni e 940mila euro, più 530mila euro di spese notarili e imposte. Un importo superiore del 10% al valore di mercato, stimato in 11 milioni e 772mila euro.
Il collegio sindacale dell’Inps, nell’approvare a denti stretti l’operazione nel dicembre 2022, ha raccomandato acidamente “per il futuro, nella fase delle trattative, una maggiore ponderazione dei margini individuati al fine di conseguire la massima economicità”. Troppo tardi: il danno era fatto.
Bilancio finale dell’operazione: dieci milioni incassati nel 2004, trenta milioni spesi tra affitti, manutenzioni e riacquisto. Un capolavoro di inefficienza.
La moltiplicazione dei disastri
Il caso di Bari non è isolato. L’Inps ha già concluso decine di operazioni analoghe, tutte in perdita. La sede di Ferrara, ricomprata dalla Finalca srl per 10 milioni e 590mila euro.

Quella di Pesaro, riacquistata per 8 milioni e 300mila euro dalla stessa società dell’imprenditore bolognese Alfredo Cazzola, ex presidente del Bologna Calcio e della Virtus Pallacanestro, che nel 2009 tentò anche l’avventura politica candidandosi sindaco per il centrodestra.
Genesi di un disastro annunciato: il governo Berlusconi e la fretta del Tesoro
Tutto inizia nel secondo governo Berlusconi, all’epoca delle famose cartolarizzazioni immobiliari. Il 9 giugno 2004, al Ministero dell’Economia guidato da Giulio Tremonti – con Domenico Siniscalco direttore generale – il Tesoro emana il decreto che costituisce il Fondo Immobili Pubblici, trasferendovi 396 immobili strumentali degli enti previdenziali.

L’operazione è seguita da quattro banche consulenti: solo una italiana, Banca Imi, le altre sono colossi internazionali destinati a fallimenti clamorosi come Lehman Brothers, oltre a Barclays e Royal Bank of Scotland.
Il primo errore, o forse la prima trappola, riguarda le valutazioni degli immobili. Invece di affidarle a un organismo pubblico, il Tesoro le commissiona a privati con evidenti conflitti di interesse. La Reag, consociata italiana dell’americana American Appraisal, si avvale della Ipi dell’immobiliarista Luigi Zunino – che l’aveva appena comprata dalla Fiat e presto l’avrebbe rivenduta al discusso Danilo Coppola, dopo aver trattato invano con Stefano Ricucci.
Il paradosso è che a indicare questa società come consulente per stabilire i valori degli immobili è la stessa Sgr di Nattino, già incaricata di gestire il fondo. Un segnale chiarissimo della direzione che avrebbe preso l’intera operazione.
Le perizie truccate e l’allarme ignorato
Le valutazioni si fermano a 3,7 miliardi per tutti i 396 immobili. Ma quando l’Agenzia del Territorio, chiamata dal Tesoro a esprimere un giudizio di congruità, esamina le stime private, scopre che il valore reale sarebbe superiore di 509 milioni. Una differenza che però “misteriosamente evapora”, come denuncerà nel 2006 una relazione esplosiva della Corte dei Conti.
L’autore del rapporto è Luigi Mazzillo, magistrato di ferro che nel 1990 Rino Formica aveva messo a capo dei superispettori del Fisco. La sua inchiesta rivela un quadro agghiacciante: non è stata svolta alcuna due diligence sui fabbricati, e nonostante fosse noto che “nella maggior parte dei casi” le dimensioni degli immobili in possesso dell’Agenzia del Demanio “divergevano in maniera significativa rispetto a quelle rilevate dalla Ipi spa”, non sono stati programmati sopralluoghi specifici.
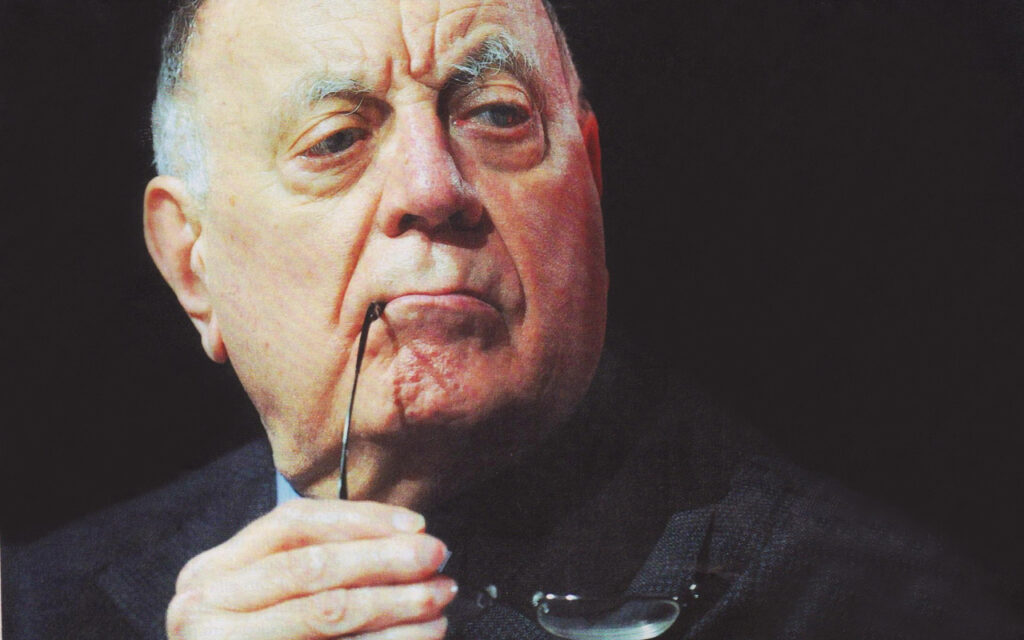
Il motivo di questa negligenza? “La mancata verifica veniva spiegata con i tempi brevi di risposta, oltre che con la considerazione che di tale verifica non fosse pervenuta nessuna richiesta da parte del Tesoro”.
Il Tesoro aveva fretta, tantissima fretta. L’operazione doveva chiudersi entro il 31 dicembre 2004, e pazienza se questo significava svendere il patrimonio pubblico. Mazzillo calcola che lo Stato è stato costretto a cedere i quasi 400 immobili per un prezzo di “ben 823 milioni al di sotto del valore di mercato”.
Il contratto capestro: affitti da usura legalizzata
Contemporaneamente alla cessione degli immobili al fondo, l’Agenzia del Demanio stipula un contratto d’affitto di nove più nove anni per i medesimi edifici, impegnandosi a pagare 270 milioni e 424.402 euro all’anno. Con un incasso di 3 miliardi e 579 milioni dalla vendita, il canone medio supera il 7,5%: quasi il doppio del costo del debito pubblico nel 2005 e una volta e mezza il tasso di rendimento medio delle locazioni commerciali a Milano, che secondo Nomisma si fermava al 5,3%.
Una follia pura, denuncia Mazzillo, “esclusivamente a beneficio delle banche e dei privati” cui il fondo venderà gli immobili. Le quattro banche consulenti, insieme alla Cassa Depositi e Prestiti, anticipano al Dipartimento del Tesoro un finanziamento di 993 milioni e quando rientrano di quei soldi, appena otto mesi dopo, intascano 99 milioni tra commissioni e altre voci, senza che nessuno al governo batta ciglio.
Condizioni da favore inimmaginabili per i compratori
Il contratto d’affitto riserva ai futuri proprietari privati condizioni da sogno. Le manutenzioni straordinarie sono tutte a carico dello Stato inquilino. Gli immobili sono esenti dal pagamento dell’Ici. E se alla scadenza dei 18 anni l’ente pubblico decidesse di trasferirsi altrove invece di ricomprare, dovrebbe lasciare i locali in perfetto stato o pagare un indennizzo. Clausola che si sta puntualmente verificando: per abbandonare un ufficio a L’Aquila, l’Inps ha dovuto versare al proprietario 34.280 euro più Iva.
Non bastasse, i canoni di affitto prendono il volo negli anni successivi. I 270 milioni concordati nel 2004 diventano 283 nel 2010, 289 nel 2012, 298 nel 2013. Per i soli 39 immobili dell’Inps, lo Stato paga nel 2014 un canone di 44 milioni e 452.765 euro, che nel 2020 lievita a 50 milioni e 953.753 euro. Un aumento del 12% che trova giustificazione in un altro regalo scandaloso.
Il cinismo di Monti: regali ai privati durante l’austerity
Luglio 2012: a Palazzo Chigi c’è Mario Monti, l’Italia è nella tempesta della crisi dei debiti sovrani, lo spread viaggia intorno ai 470 punti base. Il governo tecnico vara un decreto per “tenere sotto controllo la spesa pubblica” e “ridurre i costi per locazioni passive”. Il primo comma blocca gli adeguamenti Istat per tutti i canoni degli immobili che lo Stato prende in affitto dai privati.

Ma al comma 8 spunta la sorpresa: il blocco non si applica al Fondo Immobili Pubblici né ai suoi “aventi causa”. Mentre per tutti gli altri proprietari gli adeguamenti all’inflazione vengono congelati, per il fondo di Nattino e soci continuano a correre regolarmente. Un regalo da milioni nel momento più drammatico per le finanze pubbliche.
Il banchetto dei nuovi padroni: da Benetton a Blackstone
Al banchetto degli immobili pubblici svenduti si presenta il gotha dell’imprenditoria e della finanza italiana e internazionale. Dai gruppi Benetton e Del Vecchio ai fondi Olimpia del Kennedy Wilson Europe Real Estate, Pacific One di Blackstone e Cromwell Europa. Partecipano imprese di facility management come Miorelli, industriali della plastica come i Faraotti, singoli imprenditori come Ferruccio Zambaiti e Carlo Marini.
La famiglia Benetton, attraverso la società Regia, è anche azionista della Sgr Investire immobiliare che gestisce il fondo. Un’operazione che raggiunge il massimo del cinismo nel 2018, quando i Benetton acquistano per 150 milioni dal fondo – di cui sono azionisti – il prestigioso palazzo di Piazza Augusto Imperatore a Roma, per poi affittarlo alla catena di hotel di Bulgari.
I conti della speculazione: 117 milioni di utili ai gestori
Dal 2004 al 2021, la Sgr di Nattino e soci ha realizzato utili netti per 117,7 milioni di euro, gestendo un fondo alimentato con immobili pubblici svenduti. Nel frattempo, i contribuenti hanno pagato il conto salato dell’operazione.
I numeri parlano chiaro: a fronte di 3 miliardi e 579 milioni incassati dalla vendita dei 396 immobili, lo Stato ha sborsato attraverso l’Agenzia del Demanio canoni crescenti da 270 a 300 milioni l’anno, per un totale che supera i 5 miliardi in 18 anni. A questi si devono aggiungere i costi per le manutenzioni straordinarie, quantificabili in almeno un centinaio di milioni nel periodo 2009-2020 secondo le relazioni della Corte dei Conti.

Il risultato? Nelle mani dello Stato non è rimasto un solo mattone, mentre i privati hanno incassato profitti miliardari. E ora, per riavere indietro ciò che era già pubblico, servono altri miliardi.
La relazione sepolta e il silenzio della politica
La relazione esplosiva di Mazzillo del 2006, che denunciava tutte le irregolarità dell’operazione, è finita sepolta in un cassetto. Qualcuno l’ha tirata fuori sporadicamente negli anni successivi ma senza provocare rivoluzioni o indignazione popolare.
La politica ha taciuto, i responsabili non sono mai stati chiamati a rispondere del disastro. Anzi, molti di loro hanno continuato a fare carriera o sono tornati al governo in ruoli di primo piano.
Il déjà-vu che spaventa: la stessa maggioranza di oggi
Il dettaglio più inquietante di tutta questa vicenda è che la maggioranza politica che nel 2004 orchestrò l’operazione è la stessa che governa l’Italia oggi. Un dato che dovrebbe far riflettere sulla capacità di apprendere dagli errori del passato, soprattutto quando questi errori costano miliardi ai contribuenti.
Diciotto anni dopo, mentre gli enti pubblici sono costretti a raschiare il fondo per far quadrare i conti, devono tirare fuori altri miliardi per ricomprare ciò che avevano già venduto per favorire la speculazione privata.
Una storia che dimostra come, quando lo Stato rinuncia al controllo del proprio patrimonio, a guadagnarci sono sempre e soltanto i privati. A rimetterci, inevitabilmente, sono i cittadini che di quello Stato sono i veri proprietari.