Il 7 luglio 1976 a Catania si consumò uno degli episodi più efferati della storia criminale siciliana. Quattro adolescenti furono strangolati e gettati in un pozzo.
Catania – Benedetto Zuccaro, 15 anni. Giovanni La Greca, 14. Riccardo Cristaldi, 15. Lorenzo Pace, 14. Quattro nomi che dovrebbero essere impressi nella memoria di ogni catanese, quattro vite spezzate che raccontano una storia più grande di loro, più dolorosa, più complessa di quanto la cronaca nera possa mai restituire.
Secondo la testimonianza del pentito Antonino Calderone, il 7 luglio del 1976 quattro adolescenti furono strangolati e gettati in un pozzo dagli uomini di Cosa Nostra. Il movente? Avrebbero scippato la madre del boss etneo Nitto Santapaola. I ragazzi, subito dopo la rapina, fuggono con il loro bottino stretto fra le mani, mentre la donna, la mamma del “Cacciatore“, cade a terra rompendosi un braccio.
Santapaola, all’epoca già figura emergente del crimine organizzato catanese, sarebbe diventato negli anni successivi uno dei mammasantissima più potenti e temuti di Cosa Nostra. Nato nel 1935, aveva iniziato la sua carriera criminale negli anni ’60, scalando rapidamente le gerarchie mafiose fino a diventare il capo indiscusso della “famiglia” di Catania. La sua influenza si estendeva ben oltre i confini cittadini, arrivando a controllare traffici di droga, estorsioni e una fitta rete di alleanze con altre cosche siciliane.
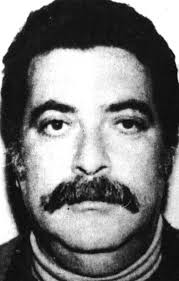
Un errore… grave… un affronto che Nitto non può ignorare. Deve dare un messaggio chiaro. La sua famiglia non si tocca, anche se sono solo quattro ragazzini, spavaldi e inesperti, inconsapevoli dei pericoli che le strade di Catania possono nascondere. E così dopo qualche tempo, Benedetto, Lorenzo, Riccardo e Giovanni, in una calda giornata estiva, tipica in Sicilia, spariscono nel nulla.
Gli uomini di Nitto li rapiscono e li portano in campagna. Da lì non faranno più ritorno. Le ricerche, quelle che si possono fare in quegli anni, con la mafia che tiene tutto sotto controllo, non portano a nulla. “Saranno scappati” dice qualcuno, ma i più sanno che un affronto tanto grave urla vendetta.
La testimonianza di Nino Calderone: il racconto dell’orrore
A svelare il mistero sulla loro sparizione è, molti anni dopo, Nino Calderone, affiliato di Santapaola, che in seguito all’arresto, diventa collaboratore di giustizia. Dopo il rapimento, Benedetto, Lorenzo, Riccardo e Giovanni vengono portati in un casolare nelle campagne nissene a due passi da Caltanissetta e tenuti senza cibo e acqua per due giorni. Cosa fare con loro? Calderone ci prova: tenta di convincere Nitto a lasciarli andare, basta una lezione per farli calmare. Ma lui non ci sta. Sanno da chi sono stati rapiti, conoscono i loro carcerieri. Li vuole morti. Quando Nitto ordina, i suoi uomini eseguono. Senza se e senza ma.
Li portano vicino a un pozzo e lì, un cugino di Calderone, li strangola con una corda, uno alla volta, e poi li getta giù. Ma con l’ultimo non ha il coraggio di stringere fino in fondo e lo butta ancora vivo insieme agli altri. Nino Calderone, assistendo al massacro dalla sua macchina, avrebbe commentato così: “Qualcuno può dirmi, ora, se ci sono giudici in grado di giudicare noialtri? O se non fa una cosa giustissima, lodevolissima, chi mi spara e mi ammazza non appena esco da questa stanza? Come potevo restare ancora dentro quella congrega maledetta? Eppure ci sono rimasto ancora diversi anni. Con questa ferita, con questo macigno dentro di me che c’è ancora e ci sarà sempre. Ecco perché mi vergogno ogni volta che entro in chiesa: perché non ce la faccio ad alzare gli occhi. Non è cinema quello che racconto”.
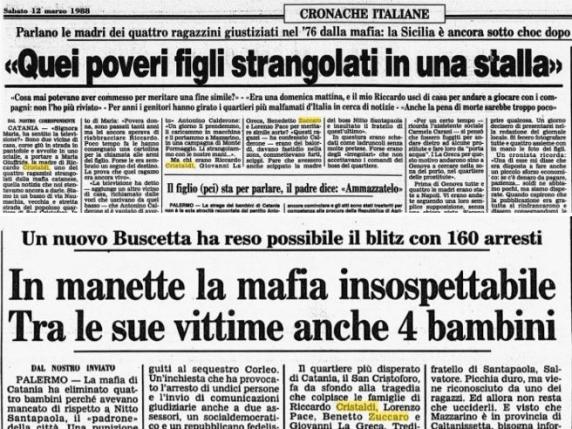
La vendetta è compiuta, lontano da occhi indiscreti, in un caldo giorno di un’estate siciliana, lontano da testimoni. Chissà se Nitto, dietro le sbarre, fra le rughe che gli solcano il viso e la certezza di essere ancora un uomo potente, ogni tanto pensa a quel giorno in cui le sue mani si sono macchiate del sangue di Benedetto, Lorenzo, Riccardo e Giovanni. Chissà se pensa a quei quattro Picciriddi e a tutte le persone che sono morte per ordine suo.
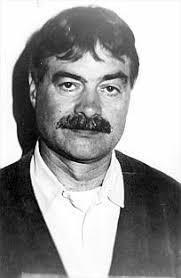
Ma questa versione dei fatti, ricostruita attraverso la testimonianza del pentito Calderone, non è mai stata vagliata da un tribunale. Non c’è stato un processo che abbia accertato le responsabilità, non ci sono state condanne, non c’è stata giustizia. Quello che rimane è il vuoto: quattro adolescenti scomparsi nel nulla, inghiottiti dal silenzio e dall’omertà che per decenni hanno avvolto la città etnea.
Vittime di un sistema che genera dannazione
Benedetto, Giovanni, Riccardo e Lorenzo erano nati poveri. Cresciuti in quartieri dove la strada educa più della scuola, dove il crimine spesso appare come l’unica via di fuga dalla miseria. Erano stati “avviati alla delinquenza”, un’espressione che suona come una condanna a morte sociale pronunciata ancora prima che questi ragazzi potessero compiere scelte consapevoli.
La loro storia è lo specchio di una città che ha sempre faticato a guardare in faccia le proprie contraddizioni. Catania, con la sua bellezza barocca e la sua vivacità culturale, ma anche con i suoi quartieri dimenticati, con i suoi giovani abbandonati a sé stessi, con le sue periferie dove la speranza è un lusso che non tutti possono permettersi.
È più facile dimenticare che ricordare, più comodo rimuovere che elaborare, più conveniente voltare pagina che fermarsi a riflettere.

Eppure, la loro storia continua a ripetersi. Ogni giorno, in qualche quartiere a rischio di Catania, ci sono adolescenti che crescono nelle stesse condizioni di abbandono, che vengono “indotti al crimine” per mancanza di alternative, che rischiano di essere strappati da questa terra nel modo più violento perché considerati scarti di una società che non sa prendersi cura dei suoi figli più vulnerabili.
La controversia sulla memoria
“Non possiamo ricordarli come vittime”, dicono i benpensanti. È un ragionamento che nasconde una logica spietata: se sei nato povero e sei finito nel crimine, allora meriti la morte. Se hai commesso reati, anche da minorenne, allora non puoi aspirare né alla pietà né alla memoria.
Ma questa logica è profondamente sbagliata e pericolosa. Riconoscere Benedetto, Giovanni, Riccardo e Lorenzo come vittime non significa giustificare i loro eventuali crimini, ma riconoscere che erano innanzitutto quattro adolescenti che non hanno mai avuto una vera possibilità di scelta. Erano vittime di un sistema che li ha partoriti già “dannati e senza speranze”, per usare un’espressione cruda ma efficace.
La loro morte violenta e la cancellazione dalla memoria collettiva rappresentano uno dei fallimenti più gravi della nostra comunità. Non solo perché quattro vite umane sono state spezzate senza giustizia ma perché il loro sacrificio non è servito a nulla: le stesse condizioni che li hanno generati continuano a esistere, le stesse dinamiche che li hanno uccisi continuano a operare.
Ogni giorno, in qualche vicolo di Librino, di San Berillo, di San Cristoforo o di altri quartieri difficili della città, ci sono ragazzini che rischiano di fare la stessa fine. Ragazzini che nascono in famiglie disgregate, che crescono senza opportunità, che vengono reclutati dalla criminalità organizzata o spicciola, che finiscono per essere considerati problemi da eliminare.

La storia di questi quattro ragazzi ci costringe a fare i conti con una verità scomoda: la civiltà e il benessere non riguardano tutti i cittadini allo stesso modo. La speranza non è distribuita equamente tra i giovani. Ci sono quartieri dove nascere significa partire già sconfitti, dove crescere significa lottare ogni giorno per la sopravvivenza, dove il futuro è un lusso che non tutti possono permettersi.
Ricordare Benedetto Zuccaro, Giovanni La Greca, Riccardo Cristaldi e Lorenzo Pace significa riconoscere che la loro morte è anche una responsabilità collettiva. Significa ammettere che una società che abbandona i suoi figli più fragili alla strada e poi li condanna quando finiscono nel crimine è una società che ha fallito.
La vera giustizia per i quattro Picciriddi non può venire solo dai tribunali, che peraltro non hanno mai avuto l’occasione (o la volontà) di pronunciarsi. La loro morte dovrebbe servire a ricordarci che dietro ogni “piccolo delinquente” c’è spesso un bambino che non ha mai avuto una vera possibilità. E che una società civile si misura proprio dalla capacità di prendersi cura dei suoi figli più vulnerabili, prima che sia troppo tardi.


