Spesso per paura di ammettere un errore preferiamo peggiorarlo. Quando accade in ambito giudiziario è una tragedia. Ma il rimedio esiste.
C’era una volta una donna. Stava cucinando una catena di salsicce in padella, quando si ricordò che mancava il vino. Scese di corsa in cantina per prenderlo, lasciando la fontana del vino aperta. Tornata su, vide che il cane aveva rubato le salsicce. Corse fuori a cercarlo, ma era sparito. Rientrando in casa, trovò il vino ormai versato dappertutto. Pensò allora di asciugarlo con la farina. Così perse le salsicce, il vino, la farina e il cane. Una perdita dietro l’altra, tutte causate dal tentativo di salvare la situazione senza affrontare l’errore iniziale. La favola — lieve, tragicomica — rivela una verità umana tanto semplice quanto spietata: che spesso, per paura di ammettere un errore, preferiamo peggiorarlo.
I Fratelli Grimm raccontano questa storia in “Federico e Caterinella“, raccolta, per la prima volta, nel 1812. Una fiaba grottesca nella forma, ma rivelatrice nella sostanza. Al di là dell’apparente ingenuità narrativa, essa incarna un meccanismo psicologico noto alla letteratura scientifica come trappola dell’investimento, o escalation irrazionale dell’impegno.
Secondo la psicologia sociale e comportamentale (Tversky & Kahneman, 1974; Arkes & Blumer, 1985), tale trappola descrive il fenomeno per cui un soggetto, dopo aver investito tempo, risorse materiali o capitale reputazionale in una scelta rivelatasi inadeguata, persiste nel perseguirla per evitare il costo psicologico del riconoscimento dell’errore. Questo costo non è solo individuale, ma identitario: ammettere l’errore equivale a mettere in discussione la propria coerenza interna, il senso del sé. In certi contesti, come quello giuridico o politico, equivale a minare la legittimità stessa del proprio ruolo pubblico.

Come osservava Hannah Arendt, «La banalità del male» non risiede in pulsioni crudeli o in menti perverse, ma spesso nell’incapacità — o nella non volontà — di pensare criticamente le proprie azioni all’interno di un sistema. La coerenza, in questa prospettiva, si trasforma da virtù morale a dispositivo di autoinganno sistemico.
L’effetto è amplificato quando l’individuo agisce in un ambiente di potere, laddove l’errore si sedimenta come fondamento narrativo del proprio operato. In ambito giudiziario, ad esempio, non è raro osservare l’effetto paradossale per cui, a fronte dell’emersione di elementi che smentiscono la fondatezza dell’accusa, l’operatore del diritto intensifica la pressione persecutoria piuttosto che arretrare. La decisione iniziale — forse fondata su premesse fallaci, su raccomandazioni informali, su bias cognitivi o rancori personali — viene difesa con crescente accanimento. In questa spirale, ogni atto successivo non corregge ma consolida l’errore, nel tentativo di renderlo legittimo retroattivamente.
Per illustrare in chiave grottesca e drammatica la logica autodistruttiva della trappola dell’investimento, val la pena evocare un celebre caso della cronaca nera americana: quello di Michael Malloy, passato alla storia come “Mike l’immortale“. Negli anni Trenta, a New York, un gruppo di uomini noti come “The Murder Trust” stipulò numerose polizze assicurative sulla vita del senzatetto Malloy, con l’intenzione di ucciderlo e incassare l’indennizzo. Ma Malloy — resistente, ignaro, inspiegabilmente fortunato — sopravvisse a ogni tentativo: alcol avvelenato, cibo marcio, gelo, gas tossico. Ogni fallimento non condusse alla rinuncia del piano, ma a un’escalation grottesca e sempre più violenta. I cospiratori, avendo investito denaro, tempo e — soprattutto — la propria reputazione tra pari, erano ormai incastrati in una rete di coerenza criminale. Più tentavano, più si compromettevano. Più fallivano, più dovevano insistere. E quando finalmente riuscirono nell’omicidio, il sistema che avevano costruito crollò con loro.
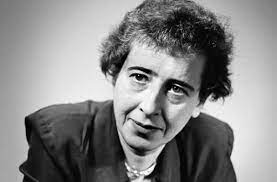
Questo caso estremo mostra un principio valido anche nei contesti istituzionali: l’incapacità di interrompere un investimento disfunzionale — sia esso giudiziario, politico o burocratico — può condurre a forme sistemiche di abuso. Ogni nuova decisione diventa parte di una narrazione, non più strumento di giustizia. L’individuo, anziché essere protetto dalla legge, ne diventa vittima: una vittima giuridicamente compatibile, socialmente compatta, moralmente abbandonata.
La protagonista della fiaba dei Grimm perde tutto per non voler affrontare la prima distrazione. Ma nella realtà contemporanea, le “salsicce” sono vite, libertà personali, reputazioni distrutte, fiducia pubblica. E il vino versato è la credibilità sistemica, spesso irrecuperabile.
Uscire dalla trappola dell’investimento richiede un lavoro intersezionale: psicologico, culturale e istituzionale. Occorre promuovere la cultura della revisione critica, in cui l’ammissione dell’errore non sia percepita come debolezza, bensì come atto di responsabilità. In ambito giuridico ciò implica introdurre meccanismi di verifica terza, percorsi di formazione continuativa sulla distorsione cognitiva (come la dissonanza cognitiva di Festinger, 1957) e, soprattutto, strumenti normativi che tutelino il diritto all’errore correggibile.
Nessuno è immune dalla trappola dell’investimento. Ma riconoscerla — con ironia se serve, con rigore sempre — è il primo passo per spezzarne la catena. Perché anche quando tutto sembra perso, si è ancora in tempo. Se non a scusarsi, almeno a fermarsi. E, magari, riparare davvero.


