Finanziamenti in calo, precariato dilagante e mancanza di prospettive spingono i giovani talenti all’estero. E il sistema universitario rischia il declino.
Le università statali italiane, secondo la definizione corrente, sono enti pubblici dotati di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e amministrativa, nell’ambito dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato italiano ed erogano titoli di istruzione superiore. Ebbene, come tutto il sistema Italia, non godono di buona salute economica e per il fatto che i migliori talenti vengono sedotti dalle sirene straniere.
Nell’ottobre scorso le società scientifiche, organizzazioni che riuniscono professionisti e ricercatori in un determinato campo scientifico per promuovere la ricerca, la formazione e la diffusione della conoscenza, in una lettera aperta hanno lanciato una sorta di “j’accuse” contro la riduzione dei fondi, 500 milioni per il 2024. Nella missiva si evidenzia la preoccupazione per i tagli alle università e alla ricerca attuati dal governo, si è parlato di “deriva” degli atenei, di riduzione dei finanziamenti e di conseguenze negative per la ricerca e l’innovazione, viene rimarcato la necessità di investire in ricerca per garantire il progresso scientifico e il futuro dell’Italia.
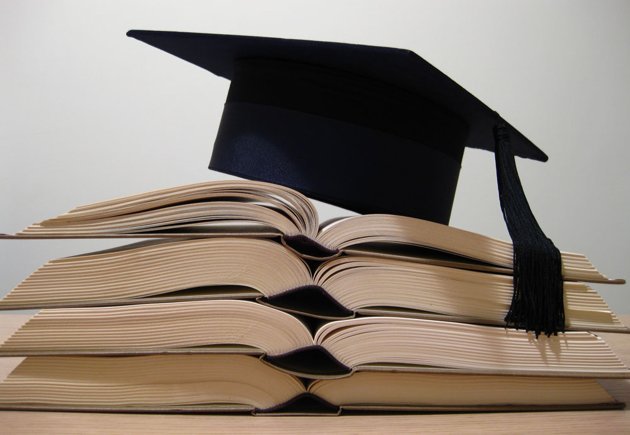
A questa se ne è aggiunta un’altra, inviata il 28 marzo scorso al ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica Anna Maria Bernini, a firma degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi. Il “casus belli” questa volta è stato il passaggio dagli “Assegni di Ricerca” (AdR), ai Contratti di Ricerca (CdR), che di fatto stanno riducendo le opzioni lavorative per i giovani ricercatori, favorendo la cosiddetta “fuga dei cervelli” e il cui accesso è molto complicato per i neo-dottorandi, malgrado col PNRR (Piano Nazionale Ripresa Resilienza) ci si era impegnati del contrario. Ma, si sa, l’Italia primeggia negli impegni non mantenuti! Comunque, le proteste hanno ottenuto, quantomeno, la sospensione del provvedimento in attesa di tempi migliori.
Sullo stato di salute dell’Università italiane si è svolto il 18 marzo scorso un convegno a cura della Scuola Normale Superiore (SNS) di Firenze. L’elenco delle criticità è lungo quanto un’autostrada. Tra queste: la quota di finanziamenti è tra le più basse, 1,5%, tra i Paesi OCSE, 2,8%; bassi finanziamenti significa crescita della precarizzazione; invecchiamento del personale docente, il che vuol dire nel prossimo triennio il 10% andrà in pensione.
Il disegno di legge, al momento accantonato, prevede solo un cambiamento formale delle regole di reclutamento e di selezione, non mutando lo status quo. L’aspetto più critico è quello a favore delle università telematiche, che producono concorrenza sleale in quanto gli studenti sono dei clienti e, quindi in qualche modo vanno soddisfatti e…rimborsati, come si diceva una volta.

Secondo il forum economico, Fondazione Nord Est, la maggioranza dei 18-34enni in fuga dal suolo patrio emigrano nelle regioni più ricche. E il salario non è il primo requisito che li motiva, ma le opportunità di carriera e la qualità della vita. Così come risulta più basso il grado di soddisfazione e benessere di chi rimane, 21%, contro il 56% di chi espatria. D’altronde, si è voluta la libera circolazione e questi sono gli effetti! Il problema è che il numero di chi viene in Italia dall’Europa è molto più basso di chi decide di andarsene, ossia l’Italia è meno seducente. Se non si attua una politica economica e sociale molto seria, il trend nei prossimi anni difficilmente cambierà direzione, ritrovandoci sempre più poveri: economicamente, demograficamente e culturalmente!


