Dall’abbattimento dell’elicottero della Guardia di Finanza ai traffici illeciti nel Mediterraneo: un caso irrisolto che ha attraversato tre decenni di depistaggi.
Muravera – Era il 2 marzo 1994 quando il cielo sereno della Sardegna meridionale fu testimone di una tragedia che ancora oggi, a trent’anni di distanza, rimane avvolta nel mistero. L’elicottero militare della Guardia di Finanza denominato Volpe 132 si inabissò al largo di Muravera poco dopo le 19, portando con sé i corpi di due uomini, mai più ritrovati: il vicebrigadiere Fabrizio Sedda, 28 anni, e il finanziere Gianfranco Deriu, 41 anni.
La missione
Il Volpe 132 stava conducendo una missione di ricognizione costiera notturna per la repressione dei traffici illeciti, coordinata dal comando dell’aeroporto di Elmas. L’elicottero operava in stretta collaborazione con l’imbarcazione guardacoste G63 Colombina, mantenendo comunicazioni radio costanti durante tutta l’operazione.
Le ultime comunicazioni dell’elicottero, registrate alle 19.07, erano perfettamente normali. I due finanzieri segnalarono la presenza di “bersagli rilevati dai radar” verso cui si stavano dirigendo, comunicando di trovarsi a Capo Carbonara e di procedere in direzione sud. Undici minuti dopo, alle 19.18, il Volpe 132 invertì bruscamente la rotta verso nord-ovest, dirigendosi verso il massiccio dei Sette Fratelli.

Fu l’ultimo segnale. Immediatamente dopo, il velivolo scomparve dai radar e le comunicazioni si interruppero per sempre.
I primi segnali di un insabbiamento
Quello che seguì quella sera solleva interrogativi inquietanti sulla gestione dell’emergenza. Nonostante l’improvvisa perdita di contatto con l’elicottero, i tentativi di stabilire comunicazioni ripresero solo alle 19.52, più di mezz’ora dopo l’inizio del silenzio radio. Il comportamento del Colombina fu altrettanto anomalo: rimase in silenzio fino alle 21.10, quando fu addirittura un traghetto civile a suggerire di mettersi alla ricerca dell’elicottero disperso.
Ancora più sospetto fu il fatto che, prima ancora che il volo venisse dichiarato ufficialmente disperso, gli armadietti personali dei due finanzieri furono forzati nella loro base a terra.
La scoperta dei frammenti e le prime contraddizioni
Nei giorni successivi, quando ormai ogni speranza di trovare i due militari in vita era svanita, furono rinvenuti alcuni frammenti dell’elicottero. La loro ubicazione, tuttavia, aggiunse ulteriori misteri al caso: i resti furono trovati a Feraxi, circa 40 chilometri dall’ultimo avvistamento radar e nella direzione opposta rispetto al percorso dichiarato dai piloti.

Ancora più significativo il fatto che l’area di ritrovamento fosse interdetta alla navigazione civile a causa di frequenti esercitazioni militari. Una coincidenza che assume contorni sinistri alla luce degli sviluppi successivi.
Le sparizioni misteriose
Le settimane seguenti furono costellate di eventi che alimentarono i sospetti di un insabbiamento. Il 26 marzo 1994, un elicottero gemello del Volpe venne sottratto da un deposito della Guardia di Finanza a Oristano, per essere poi ritrovato, smontato in pezzi, a Quartu Sant’Elena all’interno di uno stabile utilizzato da un’azienda legata ai servizi segreti.
Parallelamente, si scoprì che il radar del poligono militare di Salto di Quirra era stato spento un minuto prima della sparizione del Volpe 132.
La perizia che cambia tutto
Per anni, la versione ufficiale attribuì la tragedia all’errore umano. Una perizia del 16 maggio 1994, coperta da segreto militare (poi abolito per legge nel 1977), sosteneva questa tesi. Tuttavia, nel 2011, una nuova analisi condotta dai tecnici del RIS in collaborazione con esperti del Politecnico di Torino rivoluzionò completamente la comprensione dei fatti.
Questa perizia, basata sull’analisi forense dei pochi frammenti recuperati (circa un millesimo del velivolo), giunse a conclusioni drammatiche: l’elicottero era caduto a causa di un’esplosione. Deflagrazione che però non sarebbe stata provocata da una bomba o da un ordigno convenzionale.
La spiegazione più probabile, secondo i periti, era che un proiettile avesse colpito uno dei due serbatoi del Volpe, creando una scintilla che aveva fatto esplodere i vapori del carburante. In altre parole, il Volpe 132 non aveva avuto un incidente: era stato deliberatamente abbattuto.
Il caso della Lucina: la nave al centro del mistero
L’ipotesi dell’abbattimento ricevette supporto dalle testimonianze di quattro persone che osservarono gli ultimi momenti del Volpe da diversi punti. Alcuni testimoni riferirono di aver visto, nello stesso punto dell’abbattimento, anche la Lucina, una nave cargo della Sem Molini Sardi, di proprietà di Massimo Cellino, allora presidente del Cagliari calcio.

La Lucina era stata avvistata in ormeggio già due giorni prima della tragedia del Volpe e, secondo alcune testimonianze, si allontanò a luci spente immediatamente dopo l’abbattimento dell’elicottero. La nave sarebbe diventata tristemente nota pochi mesi dopo, il 6 luglio 1994, quando il suo intero equipaggio fu massacrato nel porto di Djen Djen, in Algeria.
Il massacro di Djen Djen: un filo rosso inquietante
Il massacro della Lucina presenta elementi che si intrecciano pericolosamente con il caso del Volpe 132. L’attacco avvenne in una zona altamente controllata del porto algerino, dove guerriglieri islamisti riuscirono a sterminare l’equipaggio e a sottrarre 600 tonnellate di carico – ufficialmente frumento – ma con ogni probabilità qualcosa di molto più prezioso e pericoloso.
L’unico sopravvissuto fu un membro dell’equipaggio che, per un contrattempo, non si era imbarcato quella notte. Successivamente si scoprì che era un agente segreto italiano infiltrato in Algeria dall’organizzazione paramilitare Gladio. Le autorità algerine parlarono di un attacco del Gruppo Islamico Armato, ma le modalità dell’azione e il carico trasportato alimentarono più di un sospetto. Alcuni collegarono la strage al traffico di armi e rifiuti tossici che in quegli anni solcava il Mediterraneo, lo stesso filone su cui stava indagando la giornalista Ilaria Alpi, assassinata a Mogadiscio poche settimane dopo la caduta del Volpe.
I traffici nel Mediterraneo: armi e scorie nucleari
Secondo le rivelazioni del pentito di ‘ndrangheta Francesco Fonti, nel marzo 1994 il Mediterraneo era al centro di intensi traffici illegali di armi e scorie nucleari. Questi traffici servivano da un lato ad alimentare i conflitti nei Balcani e nel Corno d’Africa, dall’altro permettevano ad alcune aziende europee di smaltire a basso costo rifiuti nucleari e tossici.
L’ipotesi investigativa suggerisce che la Lucina fosse coinvolta in questi traffici e che il Volpe 132, durante la sua missione di pattugliamento, si fosse imbattuto in operazioni illecite, venendo abbattuto per impedire che i due finanzieri riferissero quanto osservato.
Il collegamento con l’omicidio Alpi-Hrovatin
La connessione tra il caso del Volpe 132 e l’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e del cameraman Miran Hrovatin non è casuale. I due inviati stavano infatti indagando sugli stessi traffici di rifiuti e armi tra l’Italia e la Somalia quando furono uccisi, poche settimane dopo l’abbattimento dell’elicottero.
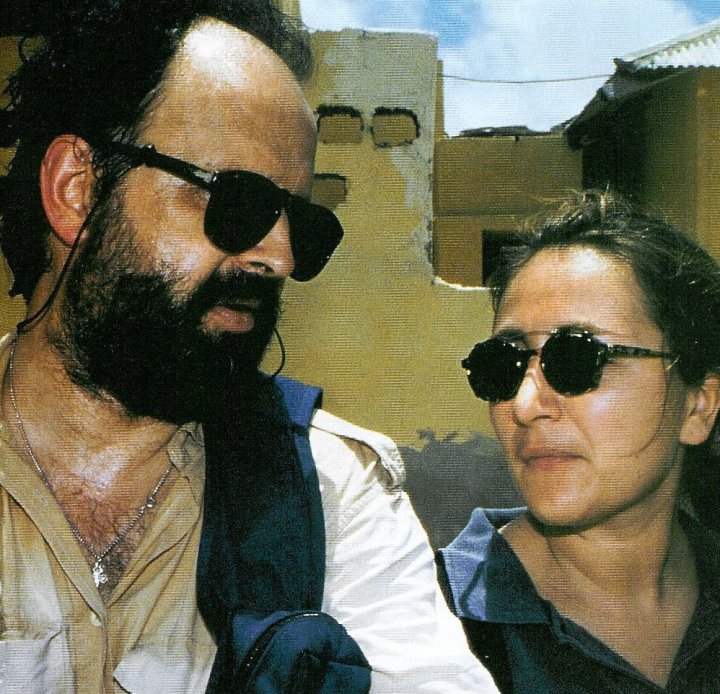
La commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio Alpi-Hrovatin ottenne l’accesso alle carte relative al Volpe 132, riconoscendo l’interconnessione tra i due casi. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avevano filmato un’intervista con un “signore della guerra” di Bosaso che aveva spiegato loro il funzionamento dei traffici illegali. Furono uccisi prima che il loro servizio potesse essere completato.
Depistaggi ed errori “casuali”
Entrambi i casi sono stati caratterizzati da una serie di errori investigativi e depistaggi che hanno ostacolato la ricerca della verità. Nel caso del Volpe 132: la ricerca iniziale dei resti in un’area marina errata, lo spegnimento “casuale” del radar, la sparizione e il successivo ritrovamento dell’elicottero gemello.
Per quanto riguarda il caso Alpi-Hrovatin: l’analisi forense condotta su un’automobile identica ma diversa da quella su cui viaggiavano i due giornalisti, e l’assassinio di Vincenzo Li Causi, fonte confidenziale di Ilaria Alpi legata a Gladio, poco prima dell’omicidio dei due inviati.
Una verità ancora sepolta
Trent’anni dopo, né il caso del Volpe 132 né quello Alpi-Hrovatin sono stati risolti. Il massacro della Lucina rimane ugualmente avvolto nel mistero, nonostante l’identificazione ufficiale dei responsabili nei guerriglieri islamisti.
Come sottolinea l’avvocato Carmelino Fenudi, che rappresenta le famiglie Sedda e Deriu: “Credo sia molto difficile arrivare alla verità oggi, soprattutto per via del grande ritardo accumulato nel tempo. Ma un testimone potrebbe davvero fare la differenza. Io credo ci siano persone che sanno benissimo cos’è successo ma non hanno ancora detto niente.”
Il riferimento dell’avvocato a coloro che “sapevano” e sono “finiti sgozzati a Djen Djen” suggerisce che la verità sia stata deliberatamente sepolta insieme ai testimoni scomodi.
Un mosaico di segreti di Stato
Il caso del Volpe 132 rappresenta molto più di una tragedia aerea irrisolta. È uno squarcio inquietante su un mondo di traffici internazionali, operazioni coperte e segreti di Stato che continuano a gettare ombre sui rapporti tra istituzioni, servizi segreti e criminalità organizzata.
La trasformazione dell’accusa da disastro aviatorio a duplice omicidio doloso nel 2011 ha ufficialmente riconosciuto che Fabrizio Sedda e Gianfranco Deriu non morirono in un incidente ma furono assassinati. Tuttavia, i mandanti e gli esecutori di questo crimine rimangono nell’ombra, protetti da un muro di silenzio che sembra rafforzarsi con il passare degli anni.
La speranza di giustizia per le famiglie Sedda e Deriu – e per la verità storica del nostro Paese – riposa ora sulla possibilità che qualcuno, tra coloro che sanno, trovi il coraggio di rompere quel silenzio che da trent’anni protegge i responsabili di un crimine che ha spezzato due vite.


